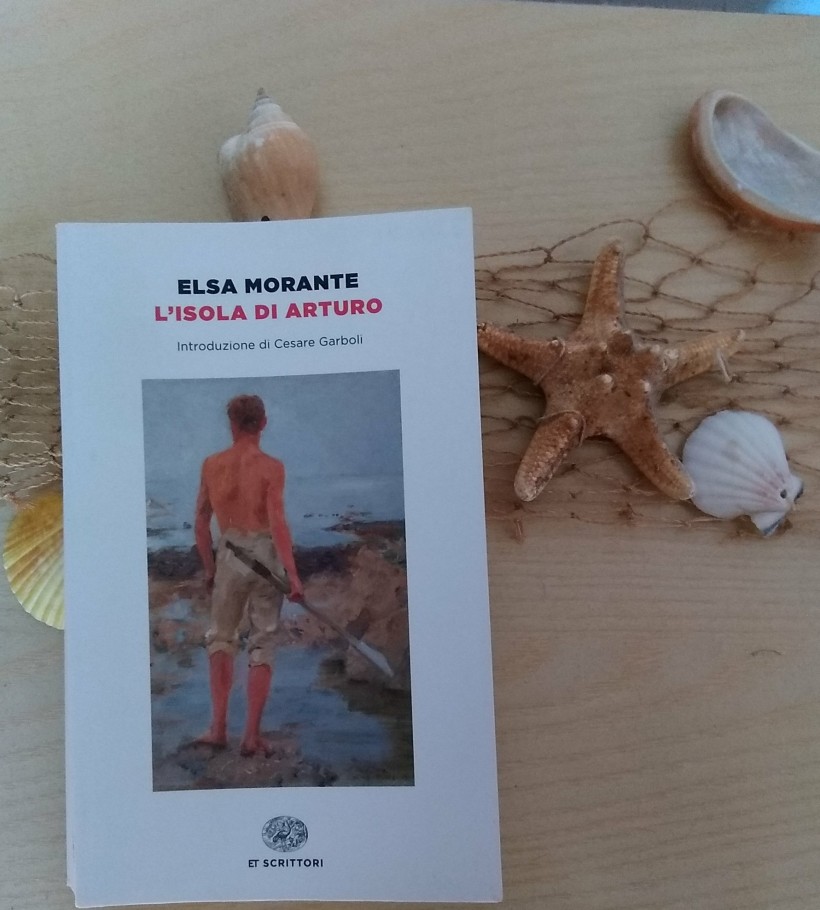In Sardegna, nella Sardegna rurale e ancestrale, il figlio partorito da una donna povera e adottato da una famiglia benestante è detto fillus de anima , “figlio dell’anima”.
Tale è la protagonista de L’Arminuta(Einaudi editore , 2019, pp. 170), breve e struggente romanzo di Donatella Di Pietrantonio , vincitore del Premio Campiello nel 2017.

Nell’agosto 1975, a tredici anni, la giovane viene riaccompagnata dal padre adottivo in seno alla famiglia di origine. La ragazzina sarà chiamata da tutti “l’arminuta”, “la ritornata”. Ella sale le scale della nuova casa con una valigia in una mano e una borsa piena di scarpe nell’altra. Ad aprirle è una bambina con le trecce sfatte: è la sorella minore Adriana. L’arminuta ha anche tre fratelli maggiori e uno ancora in fasce, Giuseppe. Vincenzo, il più grande di tutti, è affabile e protettivo con lei, mentre Sergio è polemico e litigioso. L’arminuta scrive a Adalgisa, la madre adottiva, e le confida il proprio disagio, psicologico e materiale; per tutta risposta la donna le fa recapitare un letto a castello e ogni settimana le corrisponde una piccola somma di denaro.
Ricomincia la scuola. L’arminuta viene emarginata dai compagni ma eccelle nello studio. Il destino bussa alla porta della sua nuova famiglia e Vincenzo perde la vita in un incidente con il motorino. La ragazza viene iscritta a un liceo in città; Adalgisa, le annuncia che non può ospitarla e che alloggerà nella casa della signora Bice come pensionante. Adriana vorrebbe seguirla in città ma, difronte al diniego della sorella, le urla in faccia la verità sull’abbandono da parte dei genitori adottivi. Si tratta di una rivelazione che sconvolge l’arminuta e tutte le sue certezze e la getta nella più cupa disperazione.
L’arminuta nasce due volte: quando viene alla luce e quando viene adottata. E due volte vive l’abbandono: quando i genitori biologici la cedono e quando lo zio la riporta a casa. Ella si trova catapultata da un presente sereno in un passato di cui non conserva memoria. È in una terra di nessuno: vede svanire la famiglia in cui aveva creduto e quella di origine non la sente come sua. E, due volte orfana, l’arminuta si sente defraudata degli affetti più cari e sperimenta uno strappo, una frattura nella propria vita. Non è più figlia di Adalgisa, non è ancora figlia dei genitori biologici.
Ero figlia di separazioni, parentele false o taciute, distanze. Non sapevo più da chi provenivo.
Ella non usa mai le parole “mamma” e “papà” per rivolgersi a questi ma li definisce “la madre” e “il padre”. Quando deve attirare la loro attenzione invece di chiamarli inventa espedienti per farsi notare.
Non l’ho mai chiamata, per anni. Da quando le sono stata restituita, la parola mamma si è annidata nella mia gola come un rospo che non è più saltato fuori.
Sono due universi opposti quelli in cui l’arminuta si trova scissa, anche dal punto di vista geografico; la famiglia adottiva, quella della città , la faceva sentire amata e protetta, le permetteva di frequentare la piscina e studiare danza. Ben diversa è la famiglia del paese, immersa in una realtà più prosaica e modesta; le preoccupazioni materiali soffocano le manifestazioni di affetto, una diversa cultura mette al bando le parole dolci e le coccole. È gente scabra, questa, resa ruvida dalle asperità di una vita misera e grama, fondata sul lavoro umile e sulla fatica.
Dal giorno in cui Adriana le ha aperto la porta della sua nuova casa, l’arminuta attende che lo zio-padre torni a prenderla per condurla con sé in città, questa volta per sempre. Attende pazientemente, come Penelope attende il suo Odisseo, tenacemente e instancabilmente. Nella sua ingenuità fanciullesca ella crede che Adalgisa sia malata e non voglia crearle apprensione ma, una volta guarita, tutto tornerà come prima e la vita in paese sarà solo un ricordo lontano. Ma così non è e quando Adriana si lascia sfuggire la verità tutte le speranze della sorella crollano miseramente. E la delusione, quella cocente e feroce, provoca una rabbia che prende allo stomaco, Un rancore che pulsa nelle tempie. un altro strappo, un’altra ferita nella giovane esistenza della ragazza.
Non conosciamo il nome della protagonista; per il paese è “l’arminuta”, la signorina che viene dalla città, conosce le buone maniere e parla in italiano, a differenza dei compagni di classe.
Adriana è una bimba di dieci anni, è vivace e sveglia. È suo il primo volto che l’arminuta vede all’inizio della sua nuova vita. Adriana è una guida, una spalla e una confidente per la sorella ritornata. Da lei, “fiore improbabile cresciuto su un piccolo grumo di terra attaccato alla roccia”, quella apprende la resistenza. Ma Adriana è anche la spietata Parca che recide il filo della speranza . Eppure, superato questo banco di prova, il loro legame resterà saldo anche dopo decenni.
Donatella Di Pietrantonio sceglie la soluzione omodiegetica. L’io narrante è l’arminuta che, con un periodare nervoso, ricuce la trama della propria esistenza lacerata. Frasi brevissime si rincorrono veloci a estrinsecare la tensione emotiva e gli spasmi di un’attesa lunga, dolorosa e disillusa. La scrittura scabra e asciutta della Di Pietrantonio riesce comunque a conferire grazia e delicatezza a una materia deflagrante e a una vicenda che si presenta come un groviglio di dolore e pathos . E grazie a una penna sapiente questo grumo si dipana e si scioglie nello struggimento del ricordo di una storia rivissuta alla distanza. Sono trascorsi anni e le vicissitudini dell’arminuta sono ripercorse attraverso lo schermo di una rassegnazione pacata, di un’amarezza contenuta.
Inserti dialettali contribuiscono alla caratterizzazione dei personaggi.
Quello della maternità è un tema caro alla Di Pietrantonio che lo affronta anche nei romanzi precedenti, Mia madre è un fiume , vincitore del Premio Tropea, e Bella mia che si è aggiudicato il Premio Brancati e il Premio Vittoriano Esposito Città di Celano. Sono tutti superbi ritratti al femminile, superbi ritratti di donne e di madri; donne forti e solide come le rocce d’Abruzzo. Donne sconosciute alla grande Storia ma che hanno costruito giorno dopo giorno, con tenacia e passione, la propria personale storia e quella della loro famiglia.